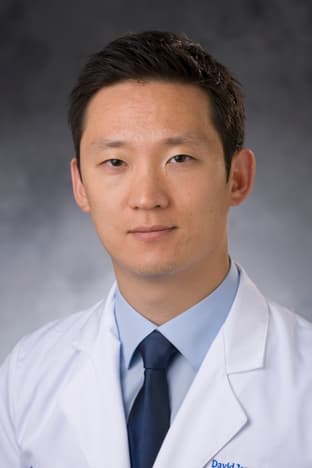Chirurgia endoscopica funzionale dei seni paranasali: mascellare, etmoide e sfenoidale (cadavere)
Main Text
Table of Contents
La chirurgia endoscopica funzionale dei seni paranasali (FESS) è una tecnica minimamente invasiva ampiamente adottata dagli anni '80 per la gestione di condizioni sinonasali come la rinosinusite cronica e la poliposi nasale. Questo articolo presenta una guida video dettagliata alla FESS su cadaverico, che illustra la dissezione passo dopo passo dei seni mascellari, etmoidi e sfenoidi. L'accento è posto sui punti di riferimento anatomici, sulla tecnica chirurgica e sull'evitare le complicanze. Destinata principalmente ai residenti e ai professionisti all'inizio della carriera, la guida mira a migliorare le competenze chirurgiche, promuovere la pratica standardizzata e, in ultima analisi, migliorare i risultati dei pazienti nella chirurgia sinonasale.
La chirurgia endoscopica funzionale dei seni paranasali (FESS), introdotta per la prima volta negli anni '80, è diventata l'approccio standard per la gestione chirurgica di varie condizioni sinonasali, come la rinosinusite cronica e la poliposi nasale. 1 Questa tecnica minimamente invasiva prevede l'uso di un endoscopio per visualizzare e accedere ai seni paranasali, consentendo una rimozione precisa e mirata del tessuto malato. La FESS ha dimostrato risultati superiori rispetto agli approcci chirurgici convenzionali. Il tasso di recidiva della poliposi nasale dopo FESS è marcatamente inferiore (6,67% dei casi), rispetto a un tasso di recidiva del 30% dopo la chirurgia convenzionale. 2 Inoltre, l'uso della FESS ha comportato una notevole riduzione del 15% della durata dell'intervento chirurgico di rinosinusite frontale rispetto alla tradizionale chirurgia a cielo aperto. 3
La rinosinusite cronica, in particolare, è una malattia sinonasale prevalente e debilitante, che colpisce tra il 5% e il 12% della popolazione generale. 4 Questa condizione infiammatoria cronica può compromettere significativamente la qualità della vita, portando a sintomi come congestione nasale, dolore facciale, mal di testa e disfunzione olfattiva. 5 Nei casi in cui la gestione medica convenzionale, compreso l'uso di corticosteroidi intranasali e antibiotici, non riesce a fornire un sollievo duraturo ai pazienti con sintomi di malattia, la FESS emerge come un intervento cardine, volto a ripristinare il normale drenaggio e ventilazione del seno attraverso la rimozione mirata del tessuto malato o ostruttivo. 6
Le potenziali complicanze associate alla FESS sono: lesione diretta al cervello, visione doppia, danno al dotto nasolacrimale/lacrimazione eccessiva, ematoma nell'orbita, formazione di sinechie, danni all'arteria carotide, danni al nervo ottico, lesioni all'orbita e perdita di liquido cerebrospinale.
In uno studio retrospettivo completo sulla chirurgia endoscopica funzionale dei seni paranasali, il tasso complessivo di complicanze è risultato essere dello 0,50%. I tassi di trasfusioni di sangue, sindrome da shock tossico, emorragia che richiede un intervento chirurgico, perdita di liquido cerebrospinale e lesioni orbitali sono stati rispettivamente dello 0,18%, 0,02%, 0,10%, 0,09% e 0,09%. 7
Il video cadaverico sulla FESS qui presentato offre una guida dettagliata e completa alla dissezione del seno mascellare, etmoidale e sfenoidale. L'approccio graduale, unito all'enfasi sulle considerazioni anatomiche, rende questo video una risorsa essenziale per gli operatori sanitari coinvolti nella gestione dei disturbi sinonasali.
La procedura inizia con il corretto posizionamento della testa del cadavere e la configurazione dello strumento. La testa del cadavere è posizionata in un modo che verrebbe utilizzato durante la procedura chirurgica vera e propria, con la testa leggermente rivolta verso il chirurgo. L'altezza del lettino è regolata in modo che il braccio del chirurgo possa appoggiarsi comodamente sul busto, riducendo al minimo l'affaticamento.
La visualizzazione iniziale con un endoscopio con angolo di visione di 0 gradi consente l'identificazione delle strutture sinonasali chiave, tra cui il turbinato inferiore, il setto e il turbinato medio. Mentre il turbinato medio è evidente nella maggior parte dei pazienti, può essere difficile da identificare nella poliposi nasale grave. In questi casi, può essere identificato più facilmente superiormente nel suo sito di attacco. Per la fase iniziale dell'operazione, l'elevatore periostale a doppia estremità viene utilizzato per spostare delicatamente il turbinato medio medialmente. Questa manovra viene eseguita con cautela per prevenire l'insorgenza di fratture della base cranica e la conseguente fuoriuscita di liquido cerebrospinale (CSF). Man mano che la medializzazione progredisce, il processo uncinato diventa evidente, insieme alla bolla etmoidale e alla lamella basale situata posteriormente dietro la bolla etmoide.
La fase procedurale successiva prevede la rimozione del processo uncinato, noto come uncinectomia. La sonda ad angolo retto viene impiegata per accedere alla faccia posteriore dell'uncinato, facilitandone la frattura anteriore. Dopo la mobilizzazione, l'uncinato viene diviso inferiormente utilizzando una pinza per la maldicenza, consentendo una rimozione precisa. Successivamente, il microdebrider viene utilizzato per eliminare i residui del processo uncinato. Con il completamento dell'uncinectomia, il passaggio successivo prevede l'individuazione dell'ostio naturale del seno mascellare. L'ostio naturale è tipicamente localizzato alla giunzione tra il turbinato medio inferiore, posizionato dietro il processo uncinato. Dopo l'ingresso riuscito, viene eseguita una leggera dilatazione del seno mascellare per migliorare la visibilità all'interno della sua cavità. Utilizzando il microdebrider, il seno mascellare viene ulteriormente allargato, in particolare nei casi in cui l'osso spesso ostruisce l'accesso. In tali casi, può essere introdotta una pinza da taglio diritta per facilitare l'apertura aggiuntiva del seno mascellare, in particolare nella parte inferiore.
Al termine dell'antrostomia mascellare, l'apertura naturale viene controllata utilizzando una sonda. Il feedback sensoriale, come sentire il tetto del seno e identificare la transizione verso la lamina papiracea, aiuta a confermare la posizione dell'ostio. Il passaggio successivo prevede la rimozione della bolla etmoide. Inizialmente, una curette a forma di J viene utilizzata per palpare la presenza del recesso retrobolare, che può variare in prominenza tra gli individui. Vengono fatti sforzi per accedere a questa rientranza, anche se occasionalmente può verificarsi l'ingresso diretto nella bolla etmoide. In questi casi, viene eseguita la frattura anteriore della bolla. La rimozione della bolla è facilitata dall'utilizzo di una pinza da taglio, che garantisce un'escissione completa. Il processo continua fino a quando la bolla etmoidale non viene completamente eliminata dal campo chirurgico.
In seguito all'escissione della bolla etmoide, la lamina papyracea diventa esposta lateralmente. Successivamente, la lamella basale viene identificata al livello corrispondente. L'ingresso nella lamella basale fornisce l'accesso alla cavità etmoidale posteriore, dove le partizioni vengono meticolosamente rimosse utilizzando microdebrider e pinze per uno sgombero completo. Per avviare la sfenoidotomia, la porzione inferiore del turbinato superiore viene resecata, creando spazio per un ulteriore accesso. Dopo la resezione dei turbinati, l'attenzione è rivolta alla localizzazione dell'ostio del seno sfenoidale. Successivamente, viene dilatato e allargato lateralmente per visualizzare l'interno del seno. Segue un'etmoidectomia da posteriore a anteriore, che scheletrizza la base del cranio rimuovendo le partizioni all'interno del seno sfenoidale. Infine, un endoscopio angolato consente la dissezione dell'incavo frontale, completando la FESS.
È fondamentale essere consapevoli delle celle d'aria Onodi. Queste cellule sono tipicamente asintomatiche, ma si trovano pericolosamente vicino al nervo ottico e all'arteria carotide interna, con una separazione ossea minima. L'errata identificazione della parete posteriore di queste cellule come seno sfenoidale durante l'ingresso endoscopico può potenzialmente danneggiare queste strutture critiche. Pertanto, un'identificazione precisa e un'attenta navigazione intorno a queste cellule sono essenziali durante la FESS per prevenire le complicanze. 8
Nel complesso, questa guida video completa su cadavere sulla FESS è una risorsa educativa essenziale che può contribuire a standardizzare le pratiche chirurgiche, migliorare la competenza del chirurgo e, in ultima analisi, ottimizzare la qualità delle cure per i pazienti con disturbi sinonasali.
Il Dr. Scott Brown è redattore di sezione presso JOMI e non è stato coinvolto nell'elaborazione editoriale di questo articolo.
Abstract aggiunto dopo la pubblicazione il 31/07/2025 per soddisfare i requisiti di indicizzazione e accessibilità. Non sono state apportate modifiche al contenuto dell'articolo.
Dai un'occhiata al resto della serie qui sotto:
References
- Bunzen DL, Campos A, Leão FS, Morais A, Sperandio F, Neto SC. Efficacia della chirurgia endoscopica funzionale dei seni paranasali per i sintomi della rinosinusite cronica con o senza poliposi. Braz J Otorinolaringolo. 2006; 72(2). DOI:10.1016/s1808-8694(15)30062-8.
- Humayun MP, Alam MM, Ahmed S, Salam S, Tarafder KH, Biswas AK. Studio comparativo degli esiti della chirurgia endoscopica dei seni paranasali e della chirurgia convenzionale per la poliposi nasale. Mymensingh Med, J., 2013; 22, paragrafo 1.
- Alekseenko S, Karpischenko S. Analisi comparativa dell'esito della chirurgia esterna ed endoscopica del seno frontale nei bambini. Acta Otorinaringolo. 2020; 140(8). DOI:10.1080/00016489.2020.1752932.
- Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, et al. EPOS 2012: Documento di posizione europeo sulla rinosinusite e i polipi nasali 2012. Un riassunto per gli otorinolaringoiatri. Rinologia. 2012; 50(1). DOI:10.4193/rinoceronte50e2.
- Hoehle LP, Philips KM, Bergmark RW, Caradonna DS, Gray ST, Sedaghat AR. I sintomi della rinosinusite cronica hanno un impatto differenziale sulla qualità della vita correlata alla salute generale. Rivista di rinologia. 2016; 54(4). DOI:10.4193/rhin16.211.
- Rosenfeld RM, Piccirillo JF, Chandrasekhar SS, et al. Linee guida per la pratica clinica (aggiornamento): sinusite dell'adulto. Otolaringolo Testa Collo Surg. 2015;152. DOI:10.1177/0194599815572097.
- Suzuki S, Yasunaga H, Matsui H, Fushimi K, Kondo K, Yamasoba T. Tassi di complicanze dopo chirurgia endoscopica funzionale del seno: analisi di 50.734 pazienti giapponesi. Laringoscopio. 2015; 125(8):1785-1791. DOI:10.1002/lary.25334.
- Gaillard F, Hacking C, Ranchod A, et al. Cella d'aria sfenoetmoidale. Articolo di riferimento, Radiopaedia.org. Consultato il 19 maggio 2024. DOI:10.53347/rID-1776.
Cite this article
Brown CS, Jang DW. Chirurgia endoscopica funzionale dei seni paranasali: mascellare, etmoidale e sfenoidale (cadavere). J Med Insight. 2024; 2024(161.1). DOI:10.24296/jomi/161.1.